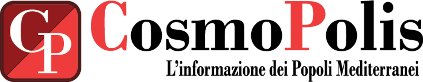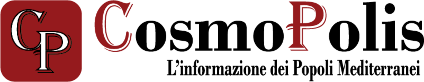Intervista ad Armando De Vincentiis, psicologo e psicoterapeuta
Una vita “inutile e inconcludente”: è questo il bilancio esistenziale che Antonio Luigi, il ragazzo di 29 anni originario di Manduria, ha affidato alle pagine del suo block notes prima di togliersi la vita.
Esami universitari mai sostenuti presso la facoltà di Medicina di Chieti, la laurea ancora lontana: ma può tutto questo essere motivo sufficiente a spingere un ragazzo al suicidio?
Un caso, quello accaduto lo scorso 6 aprile, che ci riporta alla mente episodi simili e molto vicini nel tempo: quello della studentessa di 19 anni che alla fine di gennaio si è suicidata nei bagni della Iulm, a Milano. “Fallimenti personali nella vita e nello studio“, si legge nel suo biglietto d’addio.
Qualche settimana prima la stessa dinamica si era ripetuta a Palermo, dove uno studente di Economia aveva deciso di farla finita ad una settimana dalla sessione d’esame: fallimento, la parola che accomuna il suo messaggio di commiato agli altri casi.
Secondo i dati forniti da Repubblica sono tre i suicidi avvenuti tra gli studenti nel 2022, altri tre solo dall’inizio di quest’anno.
Ma cosa scatena in questi ragazzi una voglia di morire così forte da arrivare a metterla in pratica?
Ne parliamo con il dott. Armando De Vincentiis, psicologo e psicoterapeuta.
Dott. De Vincentiis, iniziamo col dire che quasi a tutti capita di vivere, nel corso della propria esistenza, esperienze traumatiche e dolorose che ci portano a pensare di farla finita. Cosa scatta, però, nella mente di una persona che arriva a mettere in pratica questo proposito?
La spinta al suicidio è sicuramente una scelta estrema; a tutti, infatti, capita di pensare, in un dato momento della propria vita: “Voglio morire, non ce la faccio più”. Ma si tratta di metafore, di estremizzazioni che segnalano a noi stessi e agli altri che stiamo attraversando un momento particolarmente stressante e difficile.
In alcune persone, però, queste estremizzazioni diventano reali, a causa di una predisposizione emotiva che ha già determinato in loro una situazione di stress e di debolezza e può spingerli a non riuscire ad accettare una sofferenza o un conflitto.
Questa difficoltà a non accettare la sofferenza viene vissuta da questi individui in modo così estremo da portare a considerare la morte come l’unica soluzione possibile, vuoi per un eccesso di dolore patito, vuoi per una mancanza di risorse cognitive che impedisce di risolvere il problema in altro modo.
Osservando la storia clinica di un suicida, infatti, è possibile notare la presenza di prodromi legati a forme di depressione o a precedenti tentativi non andati a buon fine; tuttavia, oggi siamo tutti d’accordo nel ritenere che la volontà di togliersi la vita non è prevedibile.
Le lettere dei tre studenti di cui si parlava prima sono accomunate dalla stessa sensazione di aver fallito.
Effettivamente viviamo in un contesto dominato da perfezionismo e competizione, per cui quando non si riesce a stare al passo con gli altri si ha la sensazione di aver fallito.
Tuttavia, questa sensazione viene percepita in modo estremo da chi ha una certa predisposizione emotiva, determinata da depressione o psicopatologie di fondo, mai espresse precedentemente e che emergono solo in forti condizioni di stress. Il che spiega anche la sensazione di stupore che si prova, a volte, di fronte a reazioni esagerate emerse da individui insospettabili.
Il fallimento viene vissuto come un lutto da queste persone: si tratta del sintomo estremo di una dinamica depressiva, che culmina con il considerare la morte quale unica scelta possibile.
Società, scuola, università, famiglia: quando un ragazzo si suicida scatta sempre quasi inevitabilmente la caccia al capro espiatorio a cui addossare la responsabilità di quanto accaduto.
La nostra è una società di capri espiatori: quando accade qualcosa si va sempre a caccia di una responsabilità. Si tratta di una dinamica che fa parte del contesto sociale e nasce dall’illusione di avere sempre sotto controllo le cose.
Quando si suicida qualcuno, la colpa è sempre della famiglia, della scuola o della società: addossando la responsabilità a qualcuno, infatti, abbiamo l’illusione di controllare quello che è accaduto e impedire che possa ripetersi.
Ciò che causa questi avvenimenti, invece, dipende dal singolo e non dal contesto.
Niente caccia alle streghe, quindi; tuttavia, è altrettanto innegabile che la società odierna veda il fallimento come qualcosa da evitare ad ogni costo. Insomma, dietro la patina ipocrita dei messaggi motivazionali, l’imperativo oggi è avere successo immediato, senza fatica e senza alcun inciampo?
Occupandomi di ansia e disturbi d’ansia mi trovo a ripetere continuamente che la vera nevrosi non risiede nella presenza di un conflitto ma nella pretesa che il conflitto non esista
Il fallimento non è certamente positivo, ma ci insegna ad accettare il conflitto e a conviverci.
Non possiamo avere la pretesa di compiere un percorso di vita privo di ostacoli, pulito, lineare, senza alcun inciampo. Invece, quasi sempre, di fronte ad un fallimento personale proviamo un senso di colpa o incolpiamo qualcun altro di quanto accaduto.
La nostra società è dominata da questa nevrosi che nega spazio ad ogni tipo di fallimento e conflitto, finendo per proporre un’immagine illusoria e irrealistica della vita, che può sicuramente causare depressione.
Il fallimento va integrato nel proprio percorso di vita e accettato: solo così si realizza una vera crescita dell’individuo.
La negazione del fallimento è un nemico invisibile e silenzioso.
Si annida nei genitori che sgridano i figli per una partita di calcetto in cui non hanno segnato abbastanza goal, nell’insegnante che ti etichetta senza speranza di redenzione, nel datore di lavoro che non tollera il minimo cedimento umano e nel parente/amico che sottolinea che alla tua età “Tizio e Caio sono già laureati/sposati/con figli/con lavoro a tempo indeterminato”.
Un processo che lentamente ti convince, con una persuasione molto più efficace dei teleschermi immaginati per il 1984 da Orwell, che non vali a niente perché non hai raggiunto il massimo entro il minimo, perché il percorso che dovresti seguire ti riesce troppo difficile, in poche parole che sei inadeguato, che non hai le risorse sufficienti per stare al mondo.
E che in soggetti già predisposti può costituire l’ultimo atto di una depressione già in corso, mentre in altri può far scattare, paradossalmente, un senso di rivalsa che li conduce ad esprimere al massimo le proprie potenzialità.
Insomma stiamo realizzando individui a misura di società o società a misura di individuo?