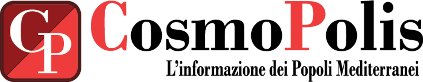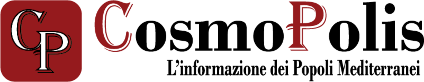Storia del Partito d’Azione. E di ciò che non si è riusciti a fare. Dotare l’Italia di una forte cultura di governo, laica e riformista, liberale e repubblicana, invece d’inseguire il conservatorismo bigotto dei due partiti-chiesa della nostra storia: la Dc e il Pci
Ciò che poteva essere e non è stato… Per responsabilità di molti. A cominciare dagli stessi protagonisti di un’idea nata con i migliori auspici. La vicenda del Partito d’Azione, la sua breve vita, si spiega, è circoscritta in queste poche parole. Nel grande contributo che, alla fine, pur auspicato da molti, venne a mancare per la crescita – e l’effettivo progresso – della democrazia italiana. Fondato nel 1942, in relazione ideale con l’omologo movimento risorgimentale d’ispirazione mazziniano, il partito si ruppe in due tronconi nel febbraio del 1946, a seguito della scissione tra le sue anime: quella riformista e repubblicana di Ugo La Malfa; e, quella della sinistra socialista, guidata da Emilio Lussu. Fu il preludio della fine, sancita dall’ultimo congresso nell’ottobre del 1947. In soli cinque anni venne consumato un sogno, idealizzato attorno alla lotta antifascista. La formazione partitica che espresse il presidente del primo governo post-liberazione (Ferruccio Parri), già effettivo capo militare della Resistenza armata, ebbe un percorso temporale breve e travagliato. La sua parabola coincise con gli anni, appunto, della Resistenza e del varo della Costituzione repubblicana. Fu testimone – e protagonista – di una stagione irripetibile della nostra storia. Quella che segnò il passaggio dalla dittatura alla democrazia. Scomparve quando la Repubblica e la Costituzione diventarono una realtà irreversibile, quasi fosse venuto meno il suo compito. Quale? Quello d’incarnare il progetto di una minoranza che, rifiutando la politica come professione, la divisione in due blocchi del sistema partitico italiano, un bipartitismo della significatività politico-istituzionale, si era impegnata in una scelta resa pregnante dalla dimensione etica dell’antifascismo. Dall’impronta aulica delle grandi idee. E dalla possibilità che l’Italia uscita dal secondo conflitto bellico potesse diventare un Paese laico e moderno.
E invece così non fu. E, quel vulnus progettuale e morale che venne a determinarsi, continua a segnare ancora oggi la qualità profonda della nostra democrazia. Scrive Giovanni De Luna, nella sua Storia del Partito d’Azione (Utet editore), “La crisi dei partiti della Prima Repubblica aveva innescato un sussulto di acre revisionismo, ma anche molteplici tentativi di appropriarsi della tradizione azionista; anzi, proprio l’eventualità che l’esperienza del PdA potesse assumere una funzione di supplenza morale e culturale per i post-comunisti e per tutto lo schieramento di sinistra, sembrò rilanciare il rancore aggressivo dei suoi critici. Ad essere attaccato fu l’azionismo come elemento fondamentale del paradigma antifascista (…)”. Il tentativo chiaro, evidente, che tornerà più volte nel dibattito pubblico del Paese, quello di matrice istituzionale, mirava senza molti fronzoli a delegittimare la Prima Repubblica e i suoi principi costitutivi. Perché, se è pur vero che la cultura azionista risultò sconfitta alla prova delle urne, i suoi presupposti teorici continuano a riecheggiare – e ad interrogarci – ancora oggi. Nonostante il tanto tempo trascorso. Ad accapigliare, ieri come oggi, i protagonisti della vita pubblica. Tanto i suoi critici (vecchi e nuovi) quanto i suoi estimatori. Ma perché si determinò un cosi colossale fallimento? Perché un partito che portava in dote una tale carica innovatrice, che sfidava le angustie dei pensieri dominanti, le ristrettezze dei circoli chiusi, si sfaldò in appena un quinquennio? Forse perché molti galli nello stesso pollaio, alla fine, non possono durare a lungo. E il PdA aveva al suo interno un personale politico di primissimo livello. Teorici ed intellettuali forgiatisi nella lotta antifascista. Non di rado in netto contrasto gli uni con gli altri. Con le idiosincrasie – e le asperità caratteriali – a prevalere su ragionamenti e obiettivi di medio e lungo periodo. L’identificazione del PdA come partito della Resistenza diverrà per molti opzione interpretativa del suo stesso fallimento.
“Per quanto mi riguarda – argomenta De Luna – non posso che riconfermare la tesi di fondo: tra il crollo del fascismo e l’avvento della Repubblica, prima di definirsi e stabilizzarsi in ‘blocchi’ contrapposti segnati su entrambi i fronti dall’egemonia dei grandi partiti di massa, il sistema politico italiano fu attraversato da una crisi profonda; soprattutto nel biennio 1943-44, si intravidero esiti diversi, le possibilità di un cambiamento più radicale, di una discontinuità molto più marcata rispetto agli assetti politici e istituzionali del fascismo e del prefascismo. Il Partito d’Azione fu il testimone, il protagonista di quella stagione, mettendo in luce tutte le potenzialità ma anche tutti i limiti: fu così rispetto alla collocazione politica dei soggetti sociali come i ceti medi, che nelle sue file sperimentarono un’ipotesi di mobilitazione politica lontana dagli schemi del loro tradizionale moderatismo. Fu così rispetto ai progetti di Stato e di società; fu così, in particolare, rispetto al costume e ai comportamenti degli italiani. Fu una scintilla che non si propagò in un incendio, subito spenta dalla glaciazione della guerra fredda e dalla logica novecentesca della massificazione delle forme della partecipazione politica”.
E tuttavia proprio perché incompiuta, quell’esperienza restò sempre nell’immaginario politico del nostro Paese. Come una possibile alternativa in grado di incarnare una sorta di perenne Stato nascente, una potenzialità inespressa che aspetta(va) solo l’occasione propizia per realizzarsi. Uno dei filoni più interessanti nella galassia azionista fu, certamente, quello liberalsocialista. La sua aggregazione ruotava attorno al binomio Capitini-Calogero. Per Capitini, il PdA doveva assolvere alla funzione di avvicinare liberali e socialisti; e farli incontrare in modo che gli uni sentissero il valore delle esigenze altrui. Capitini, inoltre, insisté molto su un disegno di riforma alimentato dall’appassionata ricerca “di una nuova vita religiosa fuori dalla tradizione ufficiale”. Di formazione esclusivamente filosofica, invece, Calogero. Rispetto alla predicazione religiosa del primo, più incline nell’analisi delle grandi ideologie del Novecento. Contro i marxisti “teologizzanti”, Calogero opponeva un attivismo più calato nello spirito del tempo. Il nucleo più vitale del liberalsocialismo finiva, così, per prescindere dalle varie opzioni del revisionismo marxista, trovando una sua originalità soprattutto nella volontà di criticare e superare il liberalismo classico, sia sul terreno dell’azione che su quello dell’ideologia e del programma politico. La svolta impressa nel 1940-41 da Calogero e Capitini alla loro elaborazione teorica si prefiggeva proprio di assecondare le istanze giovanili. Nel primo “Manifesto liberalsocialista” venivano indicati alcuni obiettivi precisi. La socializzazione delle maggiori imprese industriali, l’istituzione dei consigli di fabbrica, il garantismo che ispirava la concezione dei rapporti tra società civile e Stato.
Il PdA coltivò a lungo, nella seppur breve esistenza che lo contraddistinse, un’idea alta di riscatto del Mezzogiorno. Grazie all’elaborazione teorica di pensatori come Guido Dorso ed Ernesto Rossi insistette sul presupposto che ancorché dettata da norme e leggi, l’unità del Paese dovesse avere saldi – e pragmatici – ancoraggi socio-economici. S’interessarono della riforma agraria e di un capitalismo che mitigasse la distanza tra se stesso e la piccola proprietà contadina. La riforma proposta puntava sull’appoderamento familiare, avviando al possesso della terra famiglie con aziende autonome nelle quali potessero trovare continuo impiego tutte, o quasi tutte, le braccia delle persone che la componevano. Per Manlio Rossi Doria la radice dell’inferiorità del mezzogiorno stava nell’incapacità della sua agricoltura a organizzarsi in aziende stabili. L’area del cambiamento più esteso, al di là dell’ambito occupato, più delle strette dinamiche nominalistiche, si ergeva su corollari politici che seguivano le comuni premesse illuministiche. E s’indirizzavano attorno al “mito del buongoverno”.
Nel PdA venne sviluppandosi un filone teorico i cui protagonisti, pur all’interno della stessa collocazione sociale, si confrontarono con la società di massa, con lo sviluppo capitalistico in termini tutti proiettati verso il futuro, assumendo come priorità l’integrazione e l’assorbimento a-conflittuale delle masse nei nuovi modelli di società emergenti. Senza nessuna indulgenza per ipotesi catastrofiche, questo obiettivo venne perseguito in un disegno strategico i cui termini fondamentali restavano quelli dell’affermazione di una nuova élite politica e di una diversa ingegneria istituzionale, in grado di rompere quell’accentramento statale che aveva privato, nello sviluppo dell’unità nazionale prima, e nel fascismo dopo, lo Stato unitario del consenso/partecipazione delle masse popolare. Il confronto, quindi, avveniva dall’interno dello sviluppo capitalistico, insistendo sulla continuità tra stato liberale e fascismo, in una visione progettuale riformatrice in senso ampio che rifiutava sia lo scontro rivoluzionario con il sistema capitalistico, sia la sua negazione in nome di un mitico passato. Il pugliese Tommaso Fiore indicò i termini dell’intervento di riforma. Intervento palingenetico che doveva innervarsi sul trinomio: autonomie locali/riforma agraria/ educazione politica delle masse meridionali. Non trascurando ciò che Guido Dorso chiamò l’ideale del “trasformismo meridionale”, una sorta di cappa mortifera per la democrazia di una parte cospicua del Paese. Liberismo economico, decentramento istituzionale, ma soprattutto la sconfitta del trasformismo furono le coordinate in cui si poteva cogliere una sorta di occasione storica per l’azionismo meridionale, un’occasione di ricomposizione virtuosa, di avanzamento comune per una realtà nazionale che, diversi anni dopo, Giorgio Ruffolo definì essere troppo “lunga e stretta” da un punto di vista geografico. Temi economici, elementi storici, riforme istituzionali, ricomposizione della divaricazione tra Nord e Sud, educazione diffusa dei cittadini, modernizzazione e laicizzazione di un Paese che dopo il fascismo, continuava ad essere immobilizzato nella morsa di una condotta clericale, scelta atlantica, in un quadro di relazioni internazionali che facessero dell’Italia il fulcro di un mediterraneo crocevia di una geopolitica virtuosa, moralizzazione della vita pubblica.
Il PdA espresse il meglio dell’intelligenza – e dell’elaborazione – politica del secondo dopoguerra. Il 20 ottobre del 1947 il Consiglio nazionale della stessa formazione partitica approvava, con 64 voti contro 29, la confluenza nel Psi, ponendo fine all’esistenza giuridica del partito. “Ma si trattava di un fenomeno – ribadirà De Luna – carsico: il fiume dell’azionismo si interrava momentaneamente, pronto comunque a riaffiorare in mille rivoli e ruscelli, confluendo in una corrente sotteranea destinata ad alimentare in permanenza l’intera vicenda della sinistra nell’Italia repubblicana”. Ciò che poteva essere e non è stato… per l’appunto.